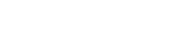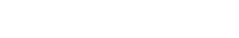HOME
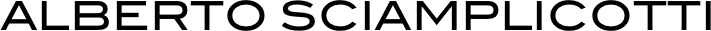
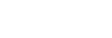
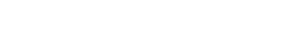

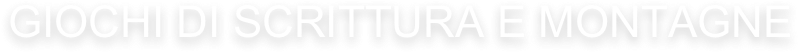
Franco Perlotto
LA TRINCEA
Il sole s’infilò di colpo dietro alle cime scure al di là del monte Obante, per affondare in uno dei tramonti incandescenti, come accadeva ogni sera in quell’ultima settimana di novembre. Il cielo d’oriente, azzurro come mai s’era visto uguale, rifilava il contorno delle sassaie che da lassù somigliavano a quelle di certe alture dolomitiche. Arcadio era avvolto dalla malinconia che investe chi tarda all’imbrunire, solitario, sulle montagne deserte. Da dove si trovava, la cima della Sisilla non era molto lontana. Cinque minuti arrampicandosi in salita l’avrebbe raggiunta. All’improvviso, l’anfiteatro di Campogrosso sembrò svanire nella penombra che quella sera non voleva trasformarsi in notte.
D’un tratto, come una biscia che sbuca repentina dal ciglio della strada, gli s’infilò in testa la decisione di non andarsene da lassù fino a quando non fosse calata ogni oscurità. La luna s’affacciò pallida poco sopra il monte Fumante, attenuata soltanto dal chiaro limpido di quella sera. Alcun senso di timore lo distolse dalla sua ammirazione. Venere gli apparve poco più in là, dove il cielo era turchino e gli dette la certezza della sua scelta.
Il vento non volle farsi sentire quella sera. Arcadio respirò profondo per riempirsi il petto d’aria muta. Si guardò le mani e se le accarezzò due volte per tastare se era ancora sveglio. Ma poi la frenesia del fare gli annodò la gola. Con uno scatto della mano prese la macchina fotografica e la infilò nello zaino che lasciava sempre aperto:
“Tanto non c’è più luce sufficiente per scattare”, si giustificò. S’avvicinò a un masso che sporgeva a due metri da lui e vi si sedette sopra.
Dietro al passo, poco sotto la vetta, s’apriva una voragine. Non era molto profonda, ma la luce radente che strisciava sulle pareti gliela fece apparire più grande. S’affacciò e la vide correre dritta per qualche metro. Poi piegava fino a sporgersi verso lo strapiombo che cadeva verso Campogrosso. Era una trincea di guerra. L’atmosfera della sera e quel solco scavato lo intristirono di colpo. Posò gli occhi dentro al buco e si perse a rimirarvi ogni sasso del fondo. Poi alzò gli occhi e spaziò verso i contorni netti delle montagne. Ma un istante dopo, come uno spillo attirato da una calamita, tornò a guardare nella vecchia trincea.
All’improvviso, come quando al battere delle ciglia sembra di scorgere qualcosa di già visto, si girò di scatto verso il prolungamento dello scavo dietro alle spalle e strinse gli occhi per penetrare la penombra. Il cuore gli dette un balzo. C’era un ragazzo appoggiato dentro alla trincea. Ai chiarori riflessi dal cielo, vide brillare il bianco di un paio di scarpe da ginnastica. Poi scorse il rosso di un berretto da baseball col frontino girato all’indietro. Gli vide le mani infilate nelle tasche grandi d’un paio di blu jeans troppo larghi per le sue gambe magre e una felpa, anch’essa rossa, che lo copriva fino a metà cosce.
“Mi hai fatto paura”, rise Arcadio. “Ti credevo un fantasma”.
“Non ci sono fantasmi quassù”, rispose il ragazzo, come indispettito.
“Ci sono quelli dei soldati del diciassette. Mi pare sempre di vederli, quando vengo sul Sengio Alto”, scherzò ancora l’uomo.
“Sempre pieni di balle voi nonni. Vivete di ricordi che non sono nemmeno vostri”.
“Non ci sono state battaglie quassù, ma lì sul Pasubio ci sono stati migliaia di morti. Dovresti averne rispetto”, borbottò Arcadio indicando verso il monte Baffelan.
“Chi va a combattere una guerra, da qualsiasi parte stia, non deve essere rispettato”, sibilò il ragazzo drizzandosi.
Si spolverò i blu jeans e quando fu ritto in piedi si pulì anche le mani. Poi appoggiò di nuovo la schiena alla parete della trincea rivolta ad oriente e incrociò una gamba sopra all’altra, come un airone addormentato nelle larghe dell’Agno giù in fondo alla valle. Alzò la testa e si lasciò scrutare da Arcadio. Aveva occhi azzurri e sulla fronte un ciuffo di capelli biondi gli uscivano dal berretto. Assunse lo sguardo di chi attende qualcuno per chiacchierare. Arcadio, passata la prima sorpresa, s’accorse di non aver voglia d’incontri e preferì restare muto a rimirare la sera che non voleva calare. Ma con la coda dell’occhio, si vide squadrare dal ragazzo con occhi tanto penetranti che l’obbligarono a chiedergli qualcosa.
“Non hai niente di meglio che startene seduto dentro ad una trincea?”, mormorò.
“Vengo spesso qui. Questo è il mio punto preferito per guardare il tramonto”.
Arcadio s’incuriosì e l’interesse per Venere, per il rosso cupo della sera e per i contorni blu delle cime ad oriente, a poco a poco si trasferì su quel ragazzo.
“Quelli della tua età vanno in discoteca. Tu invece vieni quassù ad ammirare i tramonti. Bravo.”
“Spesso di sera, saliamo in molti dal Pian delle Fugazze fino a qui in cima alla Sisilla”.
Arcadio corrugò la fronte pieno di perplessità e non seppe più cosa rispondere. Quasi voleva saltare giù dal masso e andarsene, ma il cielo era chiaro uguale di quando s’era seduto. Aveva promesso di attendere il buio e lui, la parola data a se stesso, l’avrebbe mantenuta. Finché non fosse stata notte non sarebbe partito da lì. Nemmeno il ragazzo era intenzionato ad andarsene. S’era infilato di nuovo le mani in tasca e ad Arcadio sembrò proprio uno di quei tipi del rap, che tanto odiava quando li vedeva in televisione. Gl’infilò gli occhi nei suoi e ad un tratto entrambi parvero decisi a voler chiacchierare. Arcadio, dopo un istante che sembrò eterno, ruppe irruento il silenzio:
“Che cavolo ci fai qui da solo? Sei in vacanza a Recoaro con la famiglia? Non c’è nessun’auto giù al parcheggio del rifugio, da che parte arrivi?”. Poi l’irritazione si calmò e per un attimo sopportò l’intrusione del suo spazio d’ammirazione. Si ricordò che il giovane aveva detto che veniva dal Pian delle Fugazze. Il capo del ragazzo si chinò di lato e un sorriso gli si affiorò sulle labbra. Arcadio si placò e gli chiese inutilmente:
“Come ti chiami?”
“Ivan Hartsarich. Classe 1899. Nato a Siofor, lago Balaton”, rispose.
“Non prendermi in giro, moccioso. Questo è un luogo sacro. Rispettalo”.
“Vengo dall’Ossario del passo. Siamo rimasti in tanti su queste montagne”.
“Smettila o te la mostro io l’Ungheria, a pedate sul culo”, rispose.
“Al passo ci sono oltre cinquemila italiani. La lingua l’ho imparata da loro”.
“La conosco anch’io la storia di queste montagne. Sono quassù perché la conosco meglio dei pagliacci come te che non sanno rispettare niente e nessuno”.
Arcadio sorrise al pensiero di quell’incontro. Sorrise perché quel ragazzo era davvero sveglio e, benché lo stesse prendendo in giro, conosceva bene la storia del Pasubio e delle postazioni sul Sengio Alto, per essere così giovane. Tutto sommato lo ammirò e pensò che se i suoi figli fossero stati così in gamba, anche lui avrebbe avuto più soddisfazioni nella vita. Decise di stare al gioco e di vedere fino a dove quell’imberbe conosceva le vicende della grande guerra.
“Gli austro ungarici avevano una quarantina di battaglioni sull’Ortigara. Avevano quasi quattrocento cannoni”, disse Arcadio e con la mano indicò oltre il Novegno. Guardò il cielo ancora mezzo chiaro e sospirò mentre il cuore si strusse di nostalgia per le montagne solitarie. Non percepì più il disagio per la presenza di quel ragazzo impertinente. Poi attese di continuare la chiacchierata con la stessa ansia di chi non vuole che qualcosa di bello finisca subito.
“Gli italiani avevano schierato lassù cento e cinquanta quattro battaglioni. Avevano mille e settantadue cannoni. Possedevano cinquecento sessantanove bombarde”, disse il ragazzo.
“Hai già letto molti libri di guerra, per la tua età”, sorrise Arcadio. “Chi è l’appassionato collezionista, tuo padre o tuo nonno? Ma dimmi la verità, quanti anni hai?”.
“Diciotto, te l’ho già detto”, rispose sorridendo.
“Me l’ha già detto?”, pensò Arcadio. Ma quell’età era talmente vicina alla realtà che non ebbe la forza di ribattere. Accennò ad una smorfia che doveva essere un sorriso e i suoi pensieri continuarono muti:
“Che sciocco, continua a volermi deridere. Però è davvero sveglio per riuscire a comportarsi così. Mille novecento diciassette, meno mille ottocento novanta nove, fa proprio diciotto. E’ anche bravo a fare i conti, ma adesso lo frego io”.
Schiarì la voce, quasi per tornare a farsi sentire e gli disse:
“Così saresti un soldato dell’impero. Magari sei stato addestrato a Graz”.
“Non sono nemmeno sceso dal treno, a Graz”, rispose il ragazzo. “Sono stato reclutato in Ungheria con tutti gli altri e portato direttamente a Levico in Valsugana. Era lì il campo di addestramento dei Kaiserjager”.
Arcadio non si arrabbiò nemmeno. Quello che il ragazzo aveva detto era vero. Probabilmente in casa aveva tutta la bibliografia di guerra e s’era preso la briga di leggersela. In fondo era un ragazzo in gamba e gli piaceva.
La notte non volle calare. Arcadio era incantato da quel tramonto infuocato ad occidente e dai contorni stagliati d’oriente. La luna si era spostata pallida verso le Tre Croci a sbirciare curiosa quei due uomini sulla Sisilla. Venere continuava a brillare verso meridione, unico astro nel cielo. Eppure il tempo era trascorso, lento ma inesorabile. Arcadio ebbe un impulso e guardò l’orologio. Segnava le undici e quaranta cinque. Pensò di averlo rotto, quando al pomeriggio era inciampato scendendo da cima Carega per la bocchetta Fondi. Ma l’ansia di partire s’impadronì di ogni sua azione. Scese dal masso e infilò lo zaino sulla spalla di sinistra. Anche il ragazzo si mosse dalla sua posizione e s’avviò per qualche passo dentro alla trincea in direzione di Cima Ofre.
Fu il ragazzo biondo a salutare per primo. Alzò la mano e col palmo aperto nell’aria gelida, disse:
“Se torni quassù, in cerca di tramonti forse c’incontriamo ancora”.
“Sei in gamba tu”, rispose Arcadio, mentre sgranchiva le gambe dal torpore. “Ma impara a rispettare di più questi luoghi sacri”.
“Per te sono sacri. Io disprezzo chi fa la guerra”.
Si girò come per andarsene, ma prima di allontanarsi ebbe un ultimo sorriso per Arcadio. Con piglio garbato cercò di sistemarsi il berretto da baseball col frontino al posto giusto. Ma non ce la fece al primo colpo. Voltò le spalle e con un gesto vezzoso della testa se lo tolse, mentre i capelli gli si scostarono di lato. Sul cranio, poco sopra alla nuca, Arcadio vide netto un foro rotondo. Nero e profondo. Largo un centimetro. Le gambe gli tremarono. Girò lo sguardo e s’affrettò a scendere a Campogrosso. Nemmeno si voltò più indietro. Cancellò ogni pensiero e accelerò il passo finché il fiato glielo permise. La notte scese improvvisa, pochi metri prima della strada. Al chiaro di luna, l’orologio segnava le ventiquattro e quindici minuti.